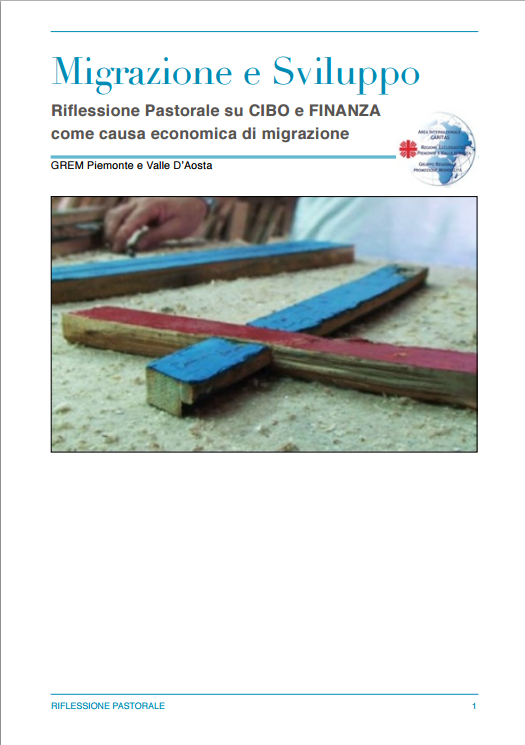Quale bellezza economica genera valore?
 Senza la bellezza non si potrebbe più vivere » scriveva Dostoevskij, ma dato che lâeconomia è un brano di vita, allora anche lâeconomia non può vivere e tantomeno può generare senza bellezza.
Senza la bellezza non si potrebbe più vivere » scriveva Dostoevskij, ma dato che lâeconomia è un brano di vita, allora anche lâeconomia non può vivere e tantomeno può generare senza bellezza.
La domanda vera da porsi allora è: quale bellezza economica è generativa di valore?
Nella mia esperienza ho fatto vari incontri con la bellezza economica. Ho visto, ad esempio, questa bellezza generativa quando a Manila ho conosciuto dei gruppi di donne di microfinanza protagonisti di progetti di microcredito: persone povere, dignitose, che esprimevano bellezza economica. Come quando ho conosciuto un imprenditore che da ragazzo era stato aiutato da imprese dellâeconomia di comunione perché non riusciva a vivere, in totale povertà nella favela dove abitava, e poi ha fatto lâimprenditore: lâaiuto ricevuto era stato perciò di carattere generativo e non assistenzialistico. Ho avuto unâesperienza di bellezza economica anche quando ho conosciuto diverse forme di cooperazione sociale e di impegno civile dove, in luoghi di cura e di assistenza, si sperimenta questa forma di bellezza: ricordo un imprenditore ligure che mi diceva di aver assunto nella sua casa di cura per persone anziane dei cuochi e dei parrucchieri, perché se dopo una malattia o un intervento una signora anziana non si sente di nuovo bella e dignitosa di attenzioni non guarisce mai, secondo lâidea che la bellezza è terapeutica. Altra esperienza di bellezza economica lâho vissuta quando in Africa, a Nairobi, ho visto gli studenti studiare di notte sotto i lampioni della luce perché in casa non avevano corrente elettrica: questa voglia di futuro e di entusiasmo per la vita è una forma di grande bellezza.
Sono tutti esempi di bellezze economiche generative e, ovviamente, quando câè questa bellezza una dimensione importante e sempre presente è quella della festa, perché la festa a differenza del divertimento implica eccedenza e gratuità , cioè non è mai un momento individualistico ma invece un bene relazionale, un rapporto di gratuità . La dimensione della gratuità e dellâeccedenza, della convivialità e della relazione che caratterizza la festa è fondamentale almeno quanto quella dei bisogni primari: oggi la gente muore anche per mancanza di rapporti e non solo di risorse.
Vulnerabilità generativa
La seconda domanda da porsi riguarda invece quale vulnerabilità è generativa in economia. A questo proposito, per esprimere il concetto in estrema sintesi, utilizzo la logica del vaccino: se, come nel vaccino, diamo spazio alle piccole vulnerabilità del quotidiano siamo poi forti di fronte alle grandi vulnerabilità ; se invece non accogliamo le piccole vulnerabilità quotidiane, quando arriva la grande vulnerabilità non riusciamo a fronteggiarla e ci distrugge. à un poâ lâesperienza che è stata fatta con questa crisi: ad esempio le banche territoriali, cooperative, che hanno accolto le vulnerabilità dei clienti sono state molto più resistenti perché hanno potuto contare su un capitale relazionale già costruito; le banche lontane dai clienti, anonime, che magari non perdono tempo con i piccoli problemi relazionali, invece, sono state travolte dalla grande vulnerabilità . Quindi solo la piccola vulnerabilità quotidiana accolta è sostenibile e robusta.
Il tema della piccola vulnerabilità non accolta è ad esempio cruciale in materia di assicurazioni: il non capire la vulnerabilità che fa parte delle vita oggi sta portando ad assicurarsi su tutto, ma con la conseguenza che ci si blocca e non si fa più nulla perché se non si ammette la possibilità della vulnerabilità non câè generatività .
Lâorigine del valore
Ma cosa genera il valore e i valori? Credo che si debba tornare alla terra, al territorio. Oggi la terra non è più vista se non come discarica o possibilità di abusivismo, la terra e i territori sono lontani dallâimmaginario delle persone. Abbiamo così dimenticato una verità fondamentale: il luogo, lâunità che genera valore è il territorio non è lâimpresa; è la coralità produttiva di un territorio che crea valore, di cui lâimpresa è una parte. Ciò che crea valore sono i rapporti allâinterno di un territorio, con la politica, le famiglie le organizzazioni civili. Quindi è necessario dotarci di una contabilità dei valori, di modalità più sofisticate per misurare il valore aggiunto di un territorio. Non capiremo il declino dellâItalia se non prendiamo in considerazione i territori che si sono impoveriti: queste reti, queste alleanze si sono impoverite e quindi non sono più capaci di generare, e unâimpresa che perde contatto con il territorio non genera più, neanche valore economico. Se non câè un patto sociale che fonde il contratto economico il mercato implode: oggi invece il patto è stato assorbito dal contratto, noi conosciamo i contratti e abbiamo dimenticato i patti, cosa che rappresenta un problema perché i patti sono fondativi dei contratti. Il patto, inoltre, è aperto alla vulnerabilità perché prevede il perdono, cosa che non avviene per il contratto. Il mercato funziona, porta frutti civili, solo se poggia su un patto, cioè su unâappartenenza comune basata sulla cooperazione prima ancora che sulla competizione. Senza unâidea di patto e di amicizia civile la competizione è distruttiva.
Si dovrebbe poi andare oltre il PIL, non tanto e non solo arricchendo le sue misurazioni ma andando a misurare i patrimoni e non solo i flussi, perché oggi per creare i flussi stiamo distruggendo i patrimoni, anche i patrimoni civili. Ma âpatrimonioâ significa âdonoâ dei padri, dei parenti, e indica ciò che abbiamo ereditato: il problema odierno è che noi lasceremo dei patrimoni molto deteriorati. Pensiamo ai patrimoni energetici: è di una gravità inaudita che noi stiamo consumando in una generazione patrimoni di energia accumulata nei milioni di anni dalla terra. Abbiamo ricevuto in eredità dei patrimoni che dobbiamo a nostra volta donare alle generazioni future, questa è la nostra responsabilità .
Stiamo ad esempio intaccando lâetica del lavoro, intesa come il lavoro ben fatto perché va fatto bene e non semplicemente perché câè lâincentivo: la pratica dellâincentivo sta distruggendo un capitale civile, perché sta trasformando la motivazione del lavorare bene da una dimensione intrinseca che attiene alla capacità professionale, al perché sono pagato. Al proposito ricordo sempre che Primo Levi raccontava come al campo di concentramento di Auschwitz, il detenuto muratore che gli portava il cibo di nascosto odiava la guerra, odiava i nazisti, odiava il cibo, ma quando lo mettevano a erigere muri li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale: questa etica oggi viene erosa dalla cultura dellâincentivo, che ha spostato la motivazione dal lavoro allâesterno di esso.
Lo zoppicare è la condizione dellâumano
Un quarto passaggio è quello per cui faccio riferimento al combattimento biblico della Genesi tra Giacobbe e lâangelo: Giacobbe vincitore ma ferito non lascia andar via lâavversario, che da uomo diventa Dio stesso, finché questo non lâha benedetto; quando lâaltro lo benedice Giacobbe diventa Israele. Lâidea di fondo è che ogni rapporto umano vero è allo stesso tempo ferita e benedizione, e una cultura della politica, dellâeconomia e del mercato che separa le persone per non farle ferire evita anche la benedizione, tanto che lâinfelicità dominante del nostro mondo è unâinfelicità da rapporti mancati, mancati per non farci male con la politica che media, la gerarchia che media, i prezzi che mediano, rischiando che la cultura della mediazione, assolutamente positiva, si trasformi in cultura dellâimmunità dei rapporti dove non ci si tocca più per non farsi male ma non ci si benedice reciprocamente. Câè un dibattito allâinterno del mondo rabbinico sul fatto che Giacobbe sia poi guarito o meno: unâinterpretazione rabbinica che mi piace molto dice che in realtà Giacobbe non guarì perché lo zoppicare è la condizione dellâumano, se smettiamo di zoppicare smettiamo di vivere.
Occorre dunque saper amare le ferite per renderle feconde, occorrono degli occhi diversi per vedere le benedizioni oltre le ferite. Nella storia per millenni questi occhi diversi li hanno forniti le religioni con i carismi, cioè doni straordinari che lâumanità ha ricevuto e hanno fatto vedere attraverso le religioni cose che gli altri non vedevano, hanno fatto intravvedere le benedizioni nelle ferite. Perché se in una ferita, collettiva o individuale, non si vede una benedizione non la si può redimere, la si può gestire in strutture ma per redimerla ci vuole lâocchio che veda dentro la ferita qualcosa di affascinante. Non basta la dimensione dellâaltruismo, ci vuole un poâ di eros per redimere una ferita, il fascino, la passione, e per far questo ci vogliono i carismi, da âcarisâ che significa gratuità ; dei doni che facciano vedere che al di là di quella ferita si nasconde una grande benedizione.
Raccontare la speranza civile
Credo che il lavoro che si sta facendo ad esempio con lâArchivio della generatività sia anche quello di far vedere i âcarismi civiliâ allâopera, cioè quanta gente è concretamente capace di vedere oltre la vulnerabilità , di trasformare delle situazioni complicate in generative e poi raccontarle. Oggi câè grande bisogno di raccontare queste cose positive, non per fare la cronaca bianca ma perché in un tempo di crisi la speranza civile è una forma di carità intellettuale: poter dire ce la possiamo fare, è possibile, câè del buono, non è semplicemente buonismo ma il dire che il dna può diventare un albero perché è sano. Il raccontarselo, il dirselo in momenti di crisi è fondamentale per farcela. Solo una speranza civile raccontata oggi può rendere sostenibile questa crisi. E il lavoro deve essere riportato al centro: oggi il lavoro non è capito perché non si vede, occorre farlo rivedere, far vedere i luoghi di lavoro, perché si vede troppo consumo e troppa finanza; lo possiamo far vedere anche raccontandolo come forma di speranza civile.